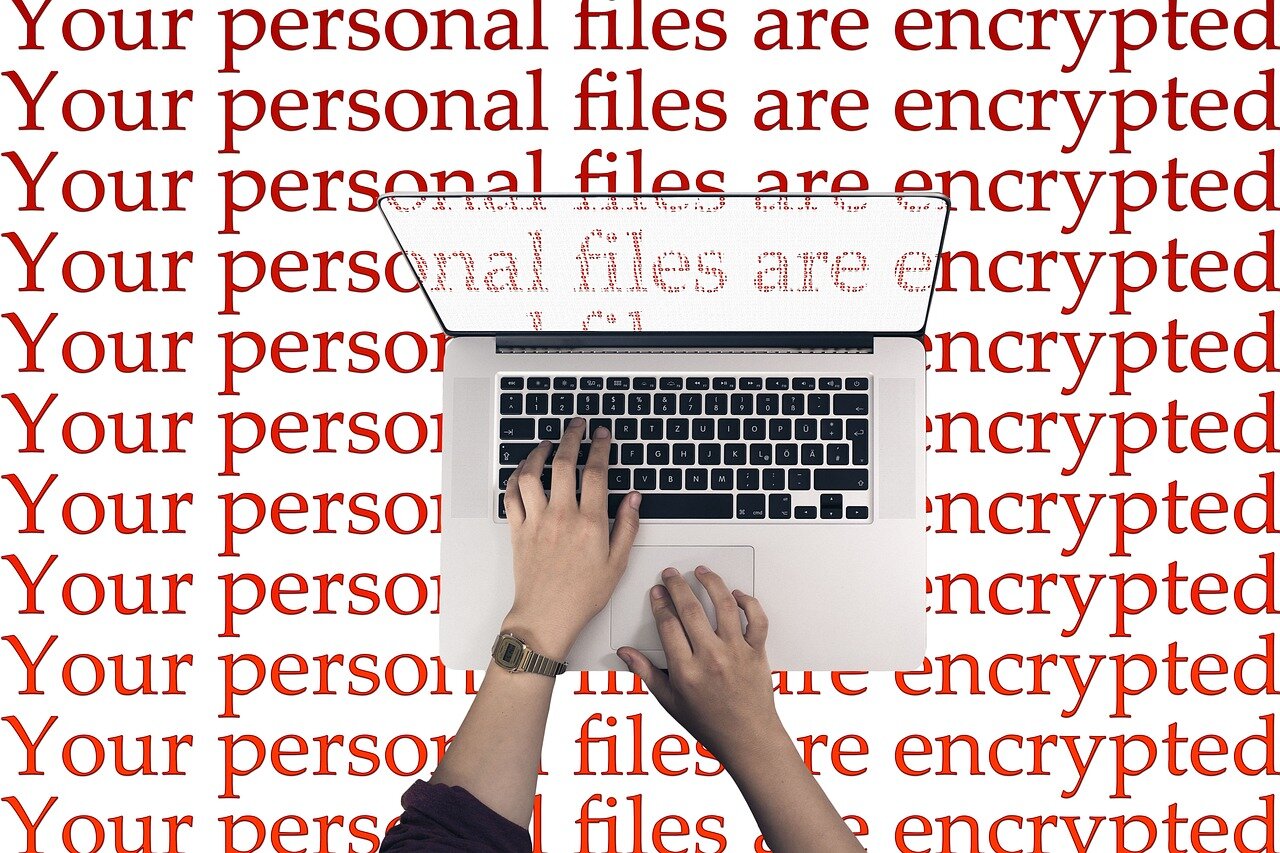Il Caso Paragon: quando la sorveglianza tocca i nervi dello Stato
Punti chiave
- Spyware su giornalisti e attivisti. Il programma Graphite, prodotto dall’azienda israelo-americana Paragon, è stato usato in Italia per sorvegliare attivisti della ONG Mediterranea e due giornalisti di Fanpage.it, tramite attacchi invisibili ai loro telefoni;
- Uso autorizzato e bersagli controversi. I contratti con Paragon erano formalmente legali e mirati a contrastare terrorismo e criminalità. Tuttavia, né i giornalisti né gli attivisti risultavano sotto inchiesta penale, e il Copasir ha escluso il coinvolgimento diretto dei servizi italiani;
- Vuoto di responsabilità. Paragon ha offerto supporto tecnico per individuare il mandante delle intercettazioni, ma l’Italia ha rifiutato. L’azienda ha poi rescisso i contratti, lasciando aperta la domanda su chi abbia realmente ordinato lo spionaggio;
- Interessi nazionali sottotraccia. La sorveglianza potrebbe rispondere a interessi strategici: contenimento dell’attivismo migratorio, protezione di relazioni con Israele e USA, e tutela dei segreti operativi dei servizi;
- Un precedente inquietante. Il caso solleva dubbi profondi su come lo Stato italiano gestisce il confine tra sicurezza e libertà. Se il giornalismo può essere sorvegliato senza spiegazioni, si apre un pericoloso varco nei principi democratici.
L’Italia è oggi coinvolta in una delle vicende più gravi degli ultimi anni sul fronte dei diritti civili: l’uso di spyware di livello militare, destinato a operazioni antiterrorismo, per colpire giornalisti e attivisti impegnati nel soccorso ai migranti. Il programma in questione è Graphite, prodotto dalla società israelo-americana Paragon Solutions, utilizzato in decine di Paesi, e che l’Italia ha impiegato tramite contratti classificati a partire dal 2023. Fin qui niente di insolito: anche altre democrazie usano strumenti simili. Ma la svolta arriva quando due cronisti di Fanpage.it , Ciro Pellegrino e Francesco Cancellato, e tre attivisti della ONG Mediterranea tra cui don Mattia Ferrari, risultano spiati attraverso programmi invisibili nei loro telefoni. La scoperta è opera del Citizen Lab (Università di Toronto), confermata dai dati forensi forniti da Apple e Meta. Non si tratta di ipotesi, perché nei dispositivi colpiti sono state trovate tracce precise del programma spia.
Graphite è uno spyware che consente accesso remoto totale al dispositivo: microfono, fotocamera, cronologia, geolocalizzazione, contatti e messaggi, anche crittografati. In pratica, chi lo controlla può trasformare un telefono in una cimice invisibile. Non si è trattato quindi di una semplice infezione ma di un vero e proprio atto di sorveglianza invasiva, potenzialmente in grado di compromettere dati sensibili anche di terzi, italiani o stranieri.
Chi li ha spiati e perché?
Secondo il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) i contratti con Paragon erano regolari, firmati per affrontare terrorismo, traffico di esseri umani e spionaggio. Le attività erano autorizzate dalla magistratura e vincolate a scopi istituzionali. Tuttavia, lo stesso Copasir ha ammesso che i giornalisti non erano oggetto di indagine penale e ha escluso un coinvolgimento diretto dei servizi italiani nel loro monitoraggio.
A questo punto emerge un vuoto. Se non sono stati i servizi italiani, chi ha ordinato l’attacco? Le ipotesi sono due:
1. Errore interno: uno scivolamento illecito all’interno degli apparati italiani;
2. Attore straniero: un servizio partner (ad esempio israeliano, europeo o NATO) che ha avuto accesso alla tecnologia tramite l’Italia.
Se l’attacco fosse stato perpetrato dall’esterno, lo scenario si farebbe ancor più inquietante. Vorrebbe dire che un attore straniero ha potuto sfruttare una tecnologia sensibile, acquistata dallo Stato italiano, per colpire cittadini italiani senza che le autorità ne fossero informate o in grado di intervenire. Questo solleverebbe interrogativi non solo sulla vulnerabilità delle nostre infrastrutture di sicurezza, ma anche sulla reale autonomia dell’Italia all’interno delle sue alleanze strategiche. In gioco, in questo caso, non ci sarebbe solo un abuso, ma la sovranità stessa.
Paragon, da parte sua, ha dichiarato di aver offerto supporto tecnico per individuare il mandante ma di essere stata ignorata e, dopo il rifiuto italiano, di aver rescisso i contratti, un’azione nient’affatto neutra.
In un settore dominato dal segreto, interrompere una collaborazione con un governo europeo significa prendere le distanze da una gestione considerata opaca o rischiosa, anche per l’azienda stessa. Non collaborare a chiarire l’origine dell’attacco lascia aperta la possibilità che, attraverso Graphite, siano stati intercettati anche dati strategici appartenenti a cittadini, attivisti e fonti italiane. Il silenzio, in questo caso, amplifica il danno.
Perché lo Stato italiano tace?
La questione diventa politica e strategica. Dietro il silenzio istituzionale si intravedono interessi nazionali difficili da ammettere apertamente, ma centrali per comprendere la vicenda. Uno di questi riguarda il controllo delle frontiere e il dossier migranti: le ONG come Mediterranea sono da anni nel mirino di una parte dell’apparato statale . In ambienti legati alla difesa e alla sicurezza, sono viste come un elemento destabilizzante per la strategia italiana di contenimento dei flussi migratori. In questo contesto, sorvegliare attivisti e mediatori umanitari – anche in modo informale o oltre i limiti giuridici – può servire a raccogliere informazioni su rotte, alleanze e meccanismi di mobilitazione.
C’è poi la dimensione geopolitica. L’acquisto di programmi spia da aziende come Paragon non è semplicemente un atto tecnico, quanto piuttosto un segnale politico. L’Italia, attraverso il DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), ha rafforzato i legami con Israele e Stati Uniti nel campo della intelligenza cibernetica. Ammettere un uso improprio di questa tecnologia potrebbe incrinare relazioni diplomatiche e industriali sensibili, mettendo a rischio l’accesso a strumenti ritenuti fondamentali per la sicurezza nazionale.
A tutto questo si aggiunge la necessità, per lo Stato, di proteggere i propri segreti operativi. Riconoscere pubblicamente un errore o un abuso significherebbe ammettere falle nei protocolli dei servizi di sicurezza, esponendosi a contenziosi interni e internazionali, in particolare con Bruxelles, che ha già sollevato dubbi sulla compatibilità di certe pratiche con i principi democratici europei.
Infine, c’è una logica più subdola, ma non meno influente: quella della costruzione del “nemico interno”. Attivisti e giornalisti che operano su temi legati alle migrazioni, alla sicurezza e ai diritti umani entrano spesso in territori scomodi. In alcuni settori dello Stato si insinua l’idea che questo tipo di indagine rappresenti un rischio per l’ordine, più che un esercizio di libertà. Da qui la tentazione di spostare il confine tra dissenso e minaccia, rendendolo sfocato. È anche per questo che, di fronte a prove tecniche difficilmente smentibili, le autorità scelgono di negare, minimizzare o deviare l’attenzione.
Dove porta tutto questo?
I contratti erano legali, nessun abuso è stato commesso. Ma la chiusura al confronto con Paragon, unita alla reticenza su chi abbia attivato l’intercettazione dei cronisti, lascia molte domande aperte. Il Copasir ha riaperto il fascicolo, ma il clima è opaco. Nel frattempo, il caso rischia di diventare un precedente, e pure pericoloso: se in una democrazia occidentale si può spiare un giornalista senza conseguenze, quale sarà il prossimo confine a cadere?
Il Caso Paragon altro non è che uno specchio – distorto ma nitido – di come lo Stato possa sacrificare la trasparenza in nome di una “sicurezza nazionale” senza volto. E di come gli interessi, se non controllati, possano valere più dei diritti.
Tuttavia, se a operare non fosse stato un apparato italiano, ma un attore straniero – magari un servizio alleato che ha sfruttato l’accesso alla tecnologia tramite l’Italia – la vicenda assumerebbe contorni ancor più inquietanti. Vorrebbe dire che un sistema di sorveglianza pensato per difendere la sovranità nazionale può essere aggirato o ceduto ad altri senza controllo democratico. In entrambi i casi, ciò che emerge è una fragilità profonda di uno Stato che, tra silenzi e reticenze, non riesce a distinguere tra sicurezza e abuso.